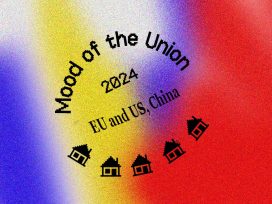L’Italia sta cambiando i rapporti con la Cina
In due anni si è passati dall’entusiasmo del primo governo Conte per gli investimenti cinesi al cambio di rotta voluto da Mario Draghi e condiviso dall’Unione europea.
Il 21 marzo 2019 il presidente cinese Xi Jinping è atterrato a Roma per firmare il memorandum d’intesa sulla Belt and road initiative (Bri, o nuova via della seta), degli accordi commerciali e istituzionali con l’Italia. Accompagnato da 500 leader politici ed economici, Xi è stato accolto con grande entusiasmo. Mettendo la sua firma su una trentina d’intese economiche, infatti, Xi Jinping rappresentava la miniera d’investimenti cinesi che avrebbero arricchito l’Italia.
L’Italia, primo paese del G7 a partecipare alla Bri, ha ignorato le critiche degli Stati Uniti e degli alleati europei. Politici e imprenditori da Trieste a Roma gongolavano davanti alla promessa di 20 miliardi di dollari d’investimenti nelle infrastrutture e alla possibilità di vedere il “made in Italy” conquistare la Cina. “L’Italia ha vinto e le aziende italiane hanno vinto”, ha dichiarato Luigi Di Maio, che all’epoca della firma era vicepresidente del consiglio. Di Maio e il Movimento 5 stelle sono stati i principali artefici dell’apertura dell’Italia verso la Cina durante il primo governo presieduto da Giuseppe Conte (2018-2019). Oggi, due anni e mezzo e due governi dopo, Roma ha un atteggiamento decisamente diverso. Anche se del governo di Mario Draghi fanno parte molti politici dei due esecutivi precedenti, il tono rispetto alla Cina è meno amichevole. Le azioni dell’Italia riflettono un calcolo diverso.
La giravolta di Luigi Di Maio
Nella primavera del 2021 Roma ha bloccato due grandi investimenti cinesi, mentre a luglio ha condiviso le critiche della Nato contro le “politiche coercitive” di Pechino. Il ministro degli esteri italiano ha chiarito la posizione del suo paese: “L’Italia è un forte partner commerciale della Cina, abbiamo relazioni storiche, ma non vanno a interferire con le relazioni che noi abbiamo con gli Stati Uniti e con la Nato”.
Ironia della sorte, quel ministro degli esteri è Luigi Di Maio. Il nuovo cammino scelto dall’Italia è il prodotto di vari fattori locali e internazionali, in cui si riflette lo scontro tra le forze che stanno modellando la politica nazionale. Questo nuovo atteggiamento influenzerà un cambiamento simile negli altri paesi europei molto attivi nei rapporti con la Cina, a cominciare da Germania e Francia? Se così fosse, si verificherebbe una svolta d’importanza transatlantica, anche perché il rapporto con la Cina è la sfida centrale della politica estera degli Stati Uniti.
Per anni l’Italia ha messo a disposizione di Pechino un ambiente accogliente. I governi che si sono succeduti, sotto pressione a causa del debito pubblico (pari al 120 per cento del pil) e di una crescita anemica, erano ansiosi di aprire le porte agli investitori cinesi carichi di contante. Nel 2017 l’Italia ha partecipato al forum inaugurale della Bri, e nel 2019 riceveva già 16 miliardi d’investimenti cinesi, terza tra i paesi dell’Unione europea (dopo Germania e Francia). Le infrastrutture italiane erano un obiettivo chiave per gli acquirenti cinesi. Oggi il 35 per cento della rete elettrica del paese e il 49 per cento del porto di Vado Ligure, il più grande terminal del Mediterraneo con magazzini frigoriferi, sono in mani cinesi. Aziende note come la Telecom, l’Unicredit e la Pirelli, così come aziende nel campo dell’intrattenimento, dello sport e dell’accoglienza, hanno soci o proprietari cinesi. Intanto i governi italiani hanno cercato di convincere l’opinione pubblica che questi investimenti non hanno una natura predatoria.
L’anno chiave è il 2008, quando la crisi economica globale ha dato a Pechino la possibilità di aumentare gli investimenti diretti esteri nelle economie avanzate del pianeta. Alla ricerca di nuove tecnologie, innovazione, reti di distribuzione migliori e sbocchi per la sua perenne sovrabbondanza di contante e produzione, la Cina ha portato enormi quantità di denaro all’estero e ha offerto aiuti generosi, soprattutto alle aziende controllate dallo stato. Il Partito comunista cinese era perfettamente consapevole del fatto che le province occidentali del paese avevano bisogno di crescere (un obiettivo cruciale della Bri) e che la numerosa classe media cinese richiedesse ormai un flusso costante di beni di consumo. L’Unione europea si è rivelata particolarmente allettante per i cinesi. Quello europeo è il mercato unico più grande del mondo e gli investimenti stranieri sono poco regolamentati. Gli accordi possono essere negoziati con i singoli stati, un metodo che permette alla Cina di ottenere condizioni più favorevoli. Mentre la crisi dell’euro colpiva i paesi dell’Europa meridionale, gli investitori cinesi arrivavano con molto denaro e soprattutto offrendo agli imprenditori europei colpiti dalla recessione la prospettiva di accedere al mercato interno cinese. La presenza dell’Unione europea offriva alla Cina un ulteriore vantaggio: la possibilità di indebolire la solidarietà europea e transatlantica. Negli ultimi anni paesi vicini a Pechino come Grecia e Ungheria hanno annacquato o bloccato le risoluzioni europee sulle dispute nel mar Cinese meridionale e sulla crisi di Hong Kong.
L’entusiasmo dell’Italia per la Cina ha raggiunto l’apice durante il governo di coalizione tra il Movimento 5 stelle e la Lega, formato nel 2018. Il leader della Lega Matteo Salvini ha visto nella Cina una forza in grado di bilanciare il potere dell’Unione europea e degli Stati Uniti, e ha sostenuto che l’Italia stava recuperando terreno. “Ci troviamo nel cuore del Mediterraneo, eppure i cinesi sono ovunque nella regione tranne che qui”, ha detto il sottosegretario allo sviluppo economico Michele Geraci, alla guida di una task force sulla Cina durante il primo governo Conte.
Dopo la fine del governo cinquestelle-Lega, fatto cadere da Salvini nel 2019, il secondo governo Conte (2019-2021) ha coinvolto voci più critiche nei confronti della Cina. L’allora ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola, del Partito democratico, ha sottolineato che “se al governo ci fossimo stati noi, il memorandum con la Cina non lo avremmo mai firmato”. Resta il fatto che nel 2017, con un governo diverso, era stato proprio il Pd ad avviare il dialogo per entrare a far parte della Bri. Il secondo governo Conte è stato più prudente del primo, e ha usato il suo potere per limitare gli investimenti e imporre restrizioni all’acquisto di tecnologie nel settore della comunicazione da parte di importanti aziende cinesi come la Huawei e la Zte. Un piano di cooperazione per la produzione di veicoli spaziali è stato messo da parte a causa delle pressioni di Washington.
L’atlantismo di Draghi
L’atmosfera tra Italia e Cina si è raffreddata ulteriormente nel 2021, quando Mario Draghi, ex presidente della Banca centrale europea, è stato nominato presidente del consiglio. Draghi ha messo subito in chiaro che l’atlantismo avrebbe indirizzato la politica del governo, compresa quella sulla Cina. A giugno Roma ha firmato la dichiarazione con cui la Nato ha sottolineato “le sfide sistemiche della Cina all’ordine internazionale basato sulle regole” e ha invitato Pechino ad “agire responsabilmente nel sistema internazionale”.
Del governo Draghi fa parte il leghista Giancarlo Giorgetti, meno favorevole di altri colleghi di partito agli investimenti cinesi. “Bene gli investimenti esteri, purché non predatori”, ha dichiarato. Ad aprile del 2021 il governo ha bloccato il tentativo di un’azienda cinese di rilevare un piccolo produttore di semiconduttori, e successivamente ha impedito a Faw, il principale produttore cinese di auto, di acquisire un’altra importante azienda italiana, l’Iveco.
La comunità cinese che vive in Italia è formata da più di trecentomila persone ed è tra le più numerose in Europa, con centri in Veneto, Lombardia e Toscana. Alcuni italiani considerano l’economia parallela gestita dai cinesi come una minaccia sia per le piccole sia per le medie imprese. Occasionalmente le operazioni della polizia italiana hanno innervosito il governo cinese.
Da tempo alcuni opinionisti manifestano una certa inquietudine rispetto alla presenza cinese in Italia. Allarmati dal crescente soft power cinese, molti hanno parlato di “offensiva di Pechino”. L’opinione sulla Cina è cambiata leggermente dopo che la risposta insufficiente dell’Unione europea alla pandemia di covid-19 ha dato a Pechino l’occasione per migliorare la propria immagine, offrendo attrezzature e aiuto finanziario. Ma la vera natura dell’intervento cinese è diventata chiara quando è emerso che la “donazione” cinese di ventilatori polmonari era in realtà una vendita concordata in precedenza, così come l’invio di medici. Il ritardo della Cina nella condivisione di informazioni e soprattutto la campagna con cui alcuni mezzi d’informazione cinesi hanno sostenuto che il virus fosse partito dall’Italia non hanno contribuito ad allentare la tensione. Nel 2021 il Mio Italia (Movimento imprese ospitalità, un’associazione di categoria) ha fatto causa al ministero della sanità cinese accusandolo di non aver comunicato subito le informazioni che aveva e di non aver agito in fretta contro il virus. Per questo il Mio ha chiesto un risarcimento di 200 milioni di euro per i danni all’industria italiana del turismo.
La vicenda di Taranto
Ancor più che in passato, oggi i leader nazionali devono tenersi in equilibrio tra i piani economici e la pressione dell’opinione pubblica. Quando nel 2020 la società turca Yilport Holdings ha firmato un accordo per ristrutturare il principale terminal del porto di Taranto, l’azienda ha dovuto smentire pubblicamente le voci secondo cui aveva una partnership con aziende cinesi. Quando sono stati firmati i contratti per la ricostruzione del ponte di Genova, gli amministratori regionali hanno subito smentito qualsiasi coinvolgimento cinese.
Anche nei casi in cui poteva essere rischiosa dal punto di vista geopolitico, la prospettiva degli investimenti cinesi in Italia ha mantenuto il suo fascino. Nel 2014 il governo italiano ha ventilato la possibilità di un’alleanza che prevedeva una forte presenza cinese nei porti di Venezia, Trieste e Genova. Anche se alla fine il progetto non si è mai concretizzato, gli accordi su Trieste e Genova hanno accompagnato l’ingresso italiano nella Bri. Per la Cina i due porti dovevano essere il fiore all’occhiello di una serie di acquisizioni in tutto il Mediterraneo.
I contrasti del passato non hanno intaccato il desiderio dell’Italia di attirare la Cina, come dimostra il caso di Taranto. Situato all’interno di un’importante zona economica e sostanzialmente equidistante da Gibilterra e dal canale di Suez, il porto di Taranto è nella posizione ideale per uno snodo commerciale. Ma dopo un lungo e frustrante negoziato, i giganti cinesi dei trasporti hanno spostato l’attenzione sul Pireo, in Grecia. L’ultima grande nave cinese ha lasciato Taranto nel 2015. Il Pireo è oggi il porto più attivo del Mediterraneo e il quarto d’Europa, mentre il principale terminal per i container di Taranto è inattivo da anni.
Nel 2020 i cinesi hanno mostrato un rinnovato interesse, e l’autorità portuale di Taranto e il presidente del consiglio italiano Giuseppe Conte hanno accolto positivamente l’iniziativa. Ma Taranto ospita anche una grande base navale italiana ed è sede di diverse operazioni multilaterali tra l’Unione europea e la Nato, e quando nel 2020 si è diffusa la notizia di un possibile intervento cinese un gruppo parlamentare che si occupa di questioni di sicurezza ha consegnato alla stampa un rapporto fortemente critico. Nel timore che la presenza di aziende cinesi controllate dallo stato, come la Huawei, potesse minacciare le attività della Nato e dell’Unione europea o compromettere le comunicazioni, l’europarlamentare italiana Anna Bonfrisco ha chiesto alla Commissione europea di esaminare la possibile vendita di una struttura considerata strategica a livello europeo, dichiarando: “Non possiamo costituire un pericolo per noi e per l’Europa intera”. Altre promesse di investimenti a Trieste e in altri porti italiani sono rimaste lettera morta.
Nel frattempo sono emerse anche preoccupazioni di natura ambientale. A Venezia la prospettiva di milioni di turisti cinesi (proposta come un incentivo agli affari) ha infatti turbato Pino Musolino, presidente dell’autorità portuale, preoccupato che si potesse distruggere ciò che rende Venezia un’amata meta turistica. Musolino ha definito la Bri “un grande progetto per controllare i flussi commerciali e le principali catene globali del valore. Se controlli questi elementi non hai più bisogno di controllare un esercito”. Anche tenendo conto dell’effetto negativo della pandemia sugli investimenti e sul commercio, finora la retorica non ha prodotto alcun beneficio concreto. Né i porti italiani né l’economia in generale hanno ottenuto un valore aggiunto dalla Bri.
In ogni caso i fattori interni, per quanto importanti, non bastano a spiegare l’inversione di rotta dell’Italia nei confronti della Cina. Alcuni importanti cambiamenti nell’orientamento degli alleati hanno permesso a Roma di assumere una posizione più sfumata e critica verso Pechino. Per i 27 paesi che ne fanno parte, l’Unione europea è il principale partner commerciale e d’investimento. Anche se buona parte dell’autorità politica è stata ceduta a Bruxelles in base al principio della “sovranità condivisa”, il potere di monitorare e dirigere gli investimenti stranieri resta nelle mani dei governi nazionali. Questo meccanismo produce un insieme di politiche incoerenti, oppure niente del tutto. Fino al 2017 la metà dei paesi dell’Unione europea non aveva una struttura di controllo degli investimenti stranieri, e lo stesso valeva per Bruxelles.
Ma con il passare del tempo l’atteggiamento europeo verso le iniziative economiche cinesi si è progressivamente fatto più severo. Durante il 2017 e il 2018 la Commissione europea, il parlamento europeo e quasi tutti gli ambasciatori dell’Unione hanno criticato la Bri e la natura squilibrata degli accordi commerciali e d’investimento. All’inizio del 2019 l’Unione europea ha definito la Cina un “concorrente economico”, attirando l’attenzione sulla crescita rapida e sregolata degli investimenti cinesi in Europa, sulla mancanza di reciprocità, sul ruolo delle aziende controllate dallo stato e sui problemi legati alla sicurezza nazionale. Germania, Francia e Italia, i primi tre paesi nella classifica degli investimenti cinesi in Europa, hanno chiesto una protezione ulteriore a livello comunitario.
Bruxelles si muove
Nel 2020 è stato finalmente messo a punto un meccanismo europeo di controllo degli investimenti diretti esteri. Il sistema identifica i settori in cui gli stati dovrebbero introdurre maggiori restrizioni, compresi quelli delle infrastrutture essenziali, della tecnologia, dell’energia, dell’accesso alle informazioni e del pluralismo dei mezzi d’informazione. Per la prima volta Bruxelles ha pubblicato un rapporto su tutti gli investimenti che non provenivano dall’Unione europea. Il rapporto ha rivelato che nel 2007 i soci cinesi controllavano cinquemila aziende, mentre nel 2017 ne possedevano più di 28mila. Il nuovo meccanismo non permette all’Unione europea di imporre restrizioni nazionali, ma sottolinea un interesse a livello europeo sugli investimenti cinesi e aumenta le contromisure in base a criteri di sicurezza e “ordine pubblico”.
A dicembre del 2020 è stato firmato un trattato sugli investimenti tra Unione europea e Cina, che prevede la prima struttura multinazionale per i negoziati con Pechino. Se ratificato, limiterà la pratica con cui la Cina costringe i partner commerciali a partecipare a joint venture per trasferire ai cinesi importanti tecnologie. Per l’Italia e altri stati dell’Unione questo significa che Pechino dovrà passare a un sistema che rappresenta 450 milioni di persone e 27 paesi anziché un singolo stato. L’Unione, in sostanza, sta facendo ciò che ha fatto l’Italia due anni fa: sta firmando un patto bilaterale con la Cina.
I diritti umani sono garantiti dalle carte fondative e dalle istituzioni dell’Unione europea. La potenza giuridica dell’Europa si è manifestata chiaramente negli anni novanta, quando Bruxelles ha imposto l’adozione di leggi a tutela dei diritti umani agli stati dell’ex blocco sovietico che aspiravano a entrare nell’Unione. Ma la Cina segue valori sociali e politici diversi. Pechino rifiuta ogni tentativo di intaccare la sua sovranità, e di conseguenza non gradisce che l’Unione europea si esprima sui suoi affari interni o su quelli regionali. Dal canto suo l’Europa non riesce a concordare una strategia efficace che trovi un equilibrio tra una politica estera basata sui suoi valori e una basata sugli interessi. Dopo il massacro di piazza Tiananmen (1989) l’Unione ha interrotto ogni rapporto con la Cina, fino a quando, nel 1995, è stato creato il dialogo sui diritti umani tra Unione europea e Cina, un meccanismo che ha permesso la ripresa dei rapporti economici. Il dialogo prevede sessioni annuali a porte chiuse in cui vengono discusse questioni relative ai diritti umani, che di solito la Cina nega o ignora.
I tentativi dell’Unione di bilanciare l’aspetto morale e quello economico non sono diversi dai dilemmi che affliggono i singoli stati. Ma nel caso dell’Unione europea tutto è complicato dal fatto che il parlamento, la Commissione e i paesi più potenti si comportano in modo diverso con la Cina. Questo ha permesso alla Germania di diventare il primo partner economico di Pechino in Europa e di difendere silenziosamente la causa dei diritti umani evitando uno scontro pubblico con il governo cinese. L’assenza di uno strumento efficace per influire sul rispetto dei diritti umani e la mancata volontà di criticare apertamente Pechino da parte di leader come Angela Merkel hanno suscitato critiche aspre. Il problema è stato reso ancora più evidente dalle prove sull’esistenza di campi di lavoro per la minoranza uigura e sulla repressione nei confronti dell’opposizione democratica di Hong Kong. Di fronte a tutto questo l’Unione europea ha cominciato ad avere una posizione comune sui diritti umani. In primavera Bruxelles ha imposto una serie di modeste sanzioni (le prime dopo piazza Tiananmen) contro alcuni funzionari del regime per il loro comportamento nello Xinjiang.
Il ruolo degli Stati Uniti
Oggi l’Europa deve affrontare la sua sfida più importante dai tempi di piazza Tiananmen. L’accordo tra la Cina e l’Unione sugli investimenti, nonostante il suo valore economico, è stato criticato perché contiene solo una vaga promessa da parte di Pechino di rispettare i diritti umani e quelli dei lavoratori. Al momento l’accordo è stato sospeso dal parlamento europeo a causa delle azioni cinesi nello Xinjiang e a Hong Kong, e delle sanzioni imposte dalla Cina per rappresaglia nei confronti di alcuni funzionari dell’Unione.
Per l’Italia un’Unione europea pronta a farsi sentire è una risorsa importante per avanzare le proprie critiche alla Cina. Lo è anche considerando l’aumento della pressione interna sul governo Draghi affinché assuma una posizione più rigida. A marzo Roma si è unita all’Unione europea nel sanzionare i funzionari cinesi accusati di aver oppresso gli uiguri, arrivando a richiamare l’ambasciatore cinese. A maggio il parlamento italiano ha approvato all’unanimità una risoluzione di condanna contro Pechino.
Il confronto con la Cina sarà il tema principale della politica estera degli Stati Uniti, almeno per il prossimo futuro. Nell’ultimo decennio a Washington si sono alternate diverse strategie. L’ex presidente statunitense Donald Trump preferiva le azioni conflittuali sul commercio e sugli investimenti. Il suo successore, Joe Biden, ha seguito lo stesso percorso improntato sullo scontro economico e politico, ma ha abbandonato la retorica aggressiva di Trump. A differenza del suo predecessore, Biden riconosce il valore della collaborazione con i più importanti alleati economici, politici e morali degli Stati Uniti su questo e su altri aspetti.
Uno dei cambiamenti più significativi nella politica statunitense è il ritorno alla cooperazione con l’Europa, e lo si può vedere nella politica adottata con la Cina. L’amministrazione Biden ha scelto la linea dura nei confronti di Pechino sulle questioni economiche, geostrategiche e sui diritti umani. I dazi introdotti da Trump non sono stati modificati e il bando contro gli investimenti nelle aziende cinesi con scopi militari è stato allargato fino a includere le aziende del settore della sorveglianza. In occasione del primo vertice tra Stati Uniti e Cina, le azioni di Pechino nello Xinjiang e a Hong Kong sono state condannate.
Per Biden l’Europa ha un ruolo centrale nei rapporti con la Cina. Sia per gli statunitensi sia per gli europei la vulnerabilità delle infrastrutture e la diffusione dell’innovazione tecnologica sono temi cruciali. Invece di cercare d’intimorire i suoi alleati come faceva Trump, Biden ha sostenuto la creazione del Consiglio per il commercio e la tecnologia tra Unione europea e Stati Uniti, che ha tra i suoi obiettivi la “cooperazione su politiche chiave che riguardano la tecnologia, le tematiche digitali e le reti di distribuzione”. Sia gli Stati Uniti sia l’Europa sono finalmente intenzionati ad affermare i propri valori. Per i paesi come l’Italia il comunicato della Nato e quello del vertice dei paesi del G7, che condannano le violazioni dei diritti umani da parte della Cina, sono un’importante piattaforma per esprimere chiaramente la propria posizione. Ovviamente questi comunicati hanno attirato l’attenzione di Pechino. Dopo il vertice della Nato il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha chiamato Luigi Di Maio, sottolineando la necessità d’intensificare i rapporti tra Italia e Cina. La risposta di Di Maio è stata piuttosto tiepida, confermando che siamo ormai a un “divorzio all’italiana”.
Nel 2019 Roma ha preso le distanze dall’Unione europea firmando la Bri, ma ha anche efficacemente messo al bando la Huawei e la Zte, cosa che il governo tedesco non ha ancora fatto. L’Italia ha intensificato i controlli sugli investimenti diretti esteri e ha bloccato due importanti progetti cinesi, ma la Faw, l’azienda che avrebbe voluto comprare l’Iveco, sta comunque investendo un miliardo di euro in una fabbrica dell’Emilia-Romagna per la produzione di auto elettriche. L’Italia ha dimostrato di essere pronta a respingere le proposte cinesi, a rafforzare i controlli sugli investimenti e (insieme agli alleati) a prendere posizione sui diritti umani. Ma la sua forza d’attrazione economica, geostrategica e politica per la Cina resta inalterata. Nel tentativo di sfruttare questo aspetto durante il ritiro dall’Afghanistan, i leader politici italiani hanno aperto canali alternativi di comunicazione con Pechino per suggerire differenti meccanismi di cooperazione nella regione.
Vari paesi europei sono ansiosi di far crescere le loro economie colpite dalla pandemia, e i loro governi devono ancora difendersi dalle offensive populiste. Se gestiti con la dovuta attenzione, il commercio e gli investimenti cinesi offrono grandi vantaggi su entrambi i fronti. Il caso italiano dimostra che è possibile avere un atteggiamento più presente e critico nei confronti della Cina, trovando un equilibrio tra le necessità economiche, il contesto nazionale, le differenze con gli alleati e il rispetto dei propri valori, e garantendo allo stesso tempo la sicurezza, gli interessi economici e forse anche la dignità nazionale.
Published 29 October 2021
Original in English
First published by Eurozine (English version) / Internazionale 1429 (Italian version)
Contributed by Internazionale © Ronald H. Linden / Emilia Zankina / Eurozine / Internazionale
PDF/PRINTIn collaboration with
In focal points
Newsletter
Subscribe to know what’s worth thinking about.